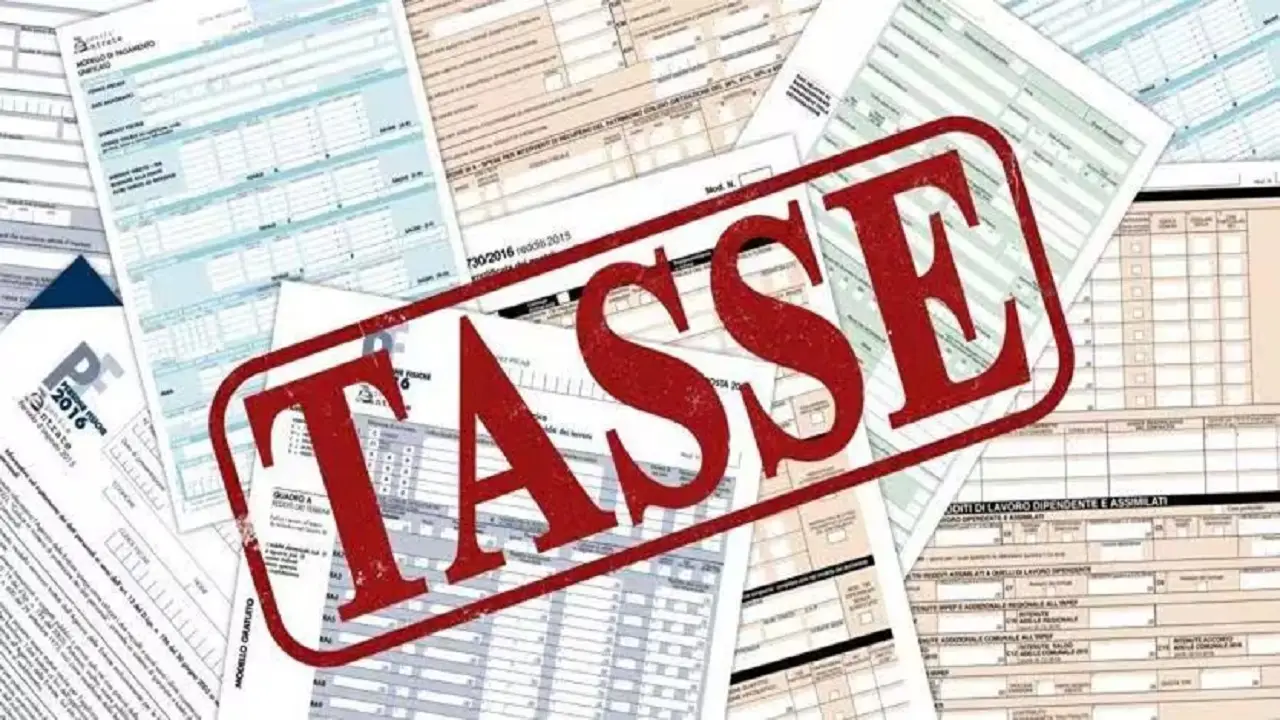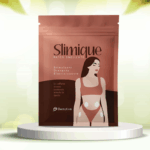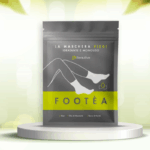L’ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto di abitazione come una prerogativa reale che conferisce a una persona il potere di occupare e utilizzare un immobile, pur non essendone proprietario. Questa situazione si verifica frequentemente nei casi di successione, specie in presenza del coniuge superstite. Ma chi è realmente tenuto al pagamento delle imposte, in particolare dell’IRPEF e delle altre principali tasse, su una casa gravata da diritto di abitazione?
Il titolare del diritto di abitazione: obblighi fiscali e ruolo rispetto al proprietario
Quando su un immobile grava il diritto di abitazione, il soggetto tenuto al pagamento delle tasse è esclusivamente il titolare di tale diritto. Il proprietario formale, pur continuando a risultare tale agli effetti civili e catastali, non è obbligato a dichiarare il bene nella propria dichiarazione dei redditi per il periodo in cui resta sospesa l’effettiva disponibilità dell’immobile a causa del diritto reale vantato da altri soggetti .
L’obbligo fiscale riguarda, in particolare, le tasse seguenti:
- IMU (Imposta Municipale Unica)
- TARI (Tassa sui rifiuti)
- Spese condominiali ordinarie
- Spese di ordinaria manutenzione
- IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
Risulta così chiaro che il soggetto titolare del diritto di abitazione ovvero, tipicamente, il coniuge superstite o chiunque abbia questo diritto inserito nel proprio titolo, è il solo a dover fronteggiare il carico fiscale e gestionale legato all’immobile .
La disciplina fiscale dell’IRPEF: casi di esenzione e obblighi dichiarativi
Per quanto riguarda in maniera specifica la dichiarazione IRPEF, la legge prevede che l’immobile oggetto di diritto di abitazione debba essere inserito nella dichiarazione dei redditi dal titolare del diritto. Tuttavia, se quell’immobile rappresenta l’abitazione principale del titolare, è possibile dedurre dal reddito complessivo la rendita catastale della medesima . Per approfondire la nozione di abitazione principale, si può consultare Wikipedia.
Nello specifico:
- La detrazione è applicabile solo se si tratta dell’immobile in cui il titolare ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente.
- Se, invece, il diritto di abitazione grava su una casa di lusso (categorie catastali A1, A8, A9), l’agevolazione viene meno e l’imposta rimane dovuta, anche se si tratta di prima casa .
In tutti gli altri casi (seconda casa, abitazione non principale, etc.), il reddito derivante dalla rendita catastale confluisce nel reddito imponibile IRPEF del titolare del diritto di abitazione, che quindi verrà tassato su tale base.
IMU, TARI e altri tributi locali: chi paga davvero?
Accanto all’IRPEF, vi sono le imposte locali, prima fra tutte l’IMU. Anche in questo fronte resta salda la regola generale: a dover versare l’IMU è il titolare del diritto di abitazione e non il proprietario formale del bene . Tuttavia, sussistono delle eccezioni e precise condizioni:
- Se l’abitazione è quella principale del titolare (con residenza e dimora abituale), si applica l’esenzione IMU prevista dalla legge per i soggetti che occupano le categorie catastali diverse da quelle di lusso.
- Le abitazioni di lusso non sono mai esenti dal pagamento IMU, neppure quando rappresentano abitazione principale.
Analoga logica è applicata alla TARI, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani: il soggetto che vive nell’immobile (ossia il titolare effettivo del diritto di abitazione e non il proprietario) risulta anche colui che produce e conferisce rifiuti, e quindi è tenuto al pagamento del tributo .
Spesso viene poi richiesto al titolare anche il pagamento delle spese condominiali ordinarie e della manutenzione ordinaria, proprio come avviene per un inquilino.
Successione, coniuge superstite e diritto di abitazione: casi pratici e dubbi frequenti
Un caso tipico è quello della successione ereditaria dopo il decesso di un familiare, scenario nel quale il coniuge superstite diventa titolare del diritto reale di abitazione sulla casa di famiglia. In questa situazione:
- Il coniuge superstite, pur non essendo proprietario esclusivo, acquista in automatico (ex articolo 540 del Codice Civile) il diritto di continuare a vivere nella casa, utilizzarla e addirittura cedere l’uso agli altri membri della famiglia.
- Di conseguenza è solo lo stesso coniuge, in qualità di titolare del diritto di abitazione, a dover sostenere direttamente i tributi previsti (IMU, TARI, IRPEF per la quota di competenza, altre spese accessorie) .
Il proprietario, invece, non avendo la disponibilità effettiva del bene e non traendone alcun reddito (l’immobile non può essere locato dal proprietario per tutto il tempo in cui dura il diritto altrui), non è tenuto al pagamento delle imposte, e l’immobile non deve neanche essere inserito nella sua dichiarazione dei redditi .
Un altro punto spesso frainteso riguarda la relazione tra usufrutto e diritto di abitazione: sebbene entrambi rappresentino diritti reali di godimento su cosa altrui, il diritto di abitazione è più ristretto, in quanto finalizzato esclusivamente a soddisfare le esigenze abitative personali e familiari del titolare, e non consente di cedere l’immobile a terzi, salvo differenza rispetto all’usufrutto (vedi usufrutto su Wikipedia).
Interpretazioni giurisprudenziali e consigli pratici
La giurisprudenza ha più volte ribadito che la titolarità del diritto di abitazione comporta l’integrale responsabilità fiscale sulle imposte e le tasse relative all’utilizzo dell’immobile. Va ricordato che il titolare dovrà curare personalmente l’inserimento dell’immobile nella propria dichiarazione dei redditi, valorizzando e deducendo la rendita catastale dove consentito, e monitorando annualmente eventuali agevolazioni o variazioni legislative.
In presenza di eredi con titolarità nuda proprietà e coniuge superstite con diritto di abitazione, l’onere tributario segue strettamente la regola: solo chi esercita il diritto di abitazione è debitore nei confronti del Fisco. Diversamente, in assenza di diritto reale, la nuda proprietà non produce alcun obbligo fino a quando non viene ripresa la piena disponibilità dell’immobile. In caso di dubbi, è sempre utile rivolgersi a un professionista esperto in diritto tributario o a un CAF qualificato prima della compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi.
In sintesi, il quadro normativo e fiscale vigente pone a carico del titolare del diritto di abitazione l’obbligo di pagare IMU, TARI, IRPEF e tutte le altre spese collegate all’uso dell’immobile, esonerando dal medesimo obbligo il proprietario, anche quando quest’ultimo figuri tra gli eredi.