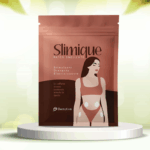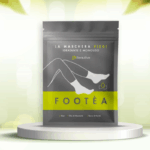Il scompenso cardiaco rappresenta una delle patologie croniche più diffuse e complesse del sistema cardiovascolare, caratterizzata dall’incapacità del cuore di pompare sangue in modo efficace per soddisfare le esigenze dell’organismo. Contrariamente a quanto spesso si pensa, non esiste un solo tipo di scompenso cardiaco: la medicina moderna riconosce diverse forme, ognuna con caratteristiche cliniche, cause, meccanismi e strategie terapeutiche specifiche. Comprendere queste differenze è fondamentale per una gestione efficace della malattia, sia per i pazienti sia per i professionisti sanitari.
Cos’è lo scompenso cardiaco: definizione e cause
Il termine scompenso cardiaco si riferisce a una condizione in cui il cuore non riesce a garantire un’adeguata perfusione sanguigna agli organi e ai tessuti, compromettendo il trasporto di ossigeno e nutrienti . Questa situazione può derivare da una serie di meccanismi:
- Ridotta forza di contrazione del muscolo cardiaco.
- Rigidità e difficoltà di rilassamento del cuore durante la fase di riempimento.
- Malattie delle valvole cardiache che ostacolano il normale flusso sanguigno.
Le principali cause di scompenso cardiaco sono:
- Infarto del miocardio e altre forme di cardiopatia ischemica.
- Cardiomiopatie di origine genetica o acquisita.
- Iptertensione arteriosa cronica.
- Malattie valvolari.
- Miocarditi (infiammazioni del cuore).
- L’abuso di alcool o sostanze tossiche.
È importante sottolineare che esistono casi in cui la causa rimane ignota, nonostante indagini cliniche approfondite.
I diversi tipi di scompenso cardiaco: classificazione moderna
La moderna classificazione dello scompenso cardiaco si basa principalmente sulla frazione di eiezione ventricolare sinistra (FEVS), ovvero la percentuale di sangue che il ventricolo sinistro espelle ad ogni contrazione. Questa parametro è fondamentale per distinguere tra le diverse tipologie:
- Scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta (HFrEF): la FEVS è ?40%.
- Scompenso cardiaco a frazione di eiezione lievemente ridotta (HFmrEF): FEVS compresa tra 41-49%.
- Scompenso cardiaco a frazione di eiezione conservata (HFpEF): FEVS ?50%.
Scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta (HFrEF)
In questa forma, detta anche “scompenso sistolico”, il cuore non si contrae con sufficiente forza. Il risultato è una minore quantità di sangue pompata ad ogni battito, con conseguente accumulo di sangue nei polmoni, nel fegato o nei tessuti periferici. Le cause principali sono infarto, cardiomiopatie dilatative e alcune forme di valvulopatia.
Scompenso cardiaco a frazione di eiezione conservata (HFpEF)
Spesso denominato “scompenso diastolico”, si verifica quando il muscolo cardiaco risulta rigido o ispessito e, pur contraendosi normalmente, non si rilassa adeguatamente, ostacolando il riempimento di sangue. Questa forma coinvolge soprattutto soggetti anziani, donne e pazienti ipertesi o diabetici, ed è oggi riconosciuta come una delle sfide più complesse della cardiologia clinica.
Frazione di eiezione lievemente ridotta (HFmrEF)
Intermedia tra le precedenti, questa categoria comprende soggetti con riduzione moderata della funzione di pompa. Le conoscenze su diagnosi e trattamento sono in rapida evoluzione.
Scompenso acuto e cronico: due modalità di presentazione
Al di là della classificazione fisiopatologica, lo scompenso cardiaco può manifestarsi come:
- Scompenso cardiaco acuto: insorge rapidamente o si aggrava in modo improvviso, spesso provocando sintomi severi come respiro corto a riposo, affanno grave, edema acuto polmonare. Può essere la prima manifestazione della malattia o una riacutizzazione di un quadro cronico.
- Scompenso cardiaco cronico: presenta un’evoluzione lenta, progressiva, con momenti di compenso (assenza di sintomi sotto trattamento) e riacutizzazioni. È la forma più studiata e diffusa nella popolazione anziana.
La progression della malattia viene spesso descritta attraverso stadi evolutivi:
- Stadio A: pazienti a rischio, senza alterazioni strutturali o sintomi.
- Stadio B: presenza di modifiche strutturali cardiache ma assenza di sintomi.
- Stadio C: anomalie strutturali con sintomi attuali o pregressi di scompenso.
- Stadio D: scompenso refrattario, sintomi importanti a riposo, necessità di interventi specialistici continui.
Valutazione della gravità: Classificazione NYHA
Oltre alla suddivisione basata sulla frazione di eiezione, la gravità dello scompenso cardiaco viene valutata secondo le classi funzionali NYHA (New York Heart Association), che definiscono il grado di limitazione nello svolgimento dell’attività fisica:
- Classe I: paziente asintomatico, nessuna limitazione alle attività ordinarie.
- Classe II: sintomi lievi con moderato sforzo fisico.
- Classe III: significativa limitazione delle attività quotidiane, sintomi con sforzi minimi.
- Classe IV: sintomi di scompenso anche a riposo.
Questa classificazione consente di monitorare nel tempo l’evoluzione della patologia e la risposta alle terapie.
I meccanismi sottostanti: scompenso sistolico vs diastolico
Dal punto di vista fisiopatologico, le principali differenze riguardano il tipo di disfunzione cardiaca:
- Scompenso sistolico: è caratterizzato da deficit di contrazione del ventricolo sinistro, tipico dell’HFrEF. Il cuore non riesce a espellere tutta la quantità di sangue che riceve, determinando congestione nei tessuti e scarso apporto di ossigeno agli organi vitali.
- Scompenso diastolico: nella HFpEF, il cuore mantiene una contrazione (sistole) efficace, ma si rilassa poco e male durante la fase di riempimento (diastole), con elevato rischio di congestione polmonare e sintomi anche a fronte di una frazione di eiezione normale.
Le cure sono diverse: mentre nel primo caso si punta a potenziare la forza contrattile e ridurre il carico emodinamico, nel secondo è fondamentale migliorare il rilassamento del cuore e tenere sotto controllo i fattori di rischio come ipertensione, obesità o diabete.
Implicazioni terapeutiche ed evoluzione clinica
Il riconoscimento del tipo di scompenso cardiaco condiziona la scelta della terapia, che può includere:
- Farmaci inotropi o vasodilatatori per l’HFrEF.
- Diuretici e controllo dei fattori di rischio per la HFpEF.
- Dispositivi come pacemaker o defibrillatori impiantabili (in casi selezionati di scompenso avanzato).
La gestione integrata e multidisciplinare è essenziale per migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti.
In sintesi, il scompenso cardiaco è una patologia complessa e sfaccettata, che si declina in forme con differente prognosi, necessità diagnostiche e opzioni terapeutiche. Solo attraverso una corretta classificazione e l’individuazione del tipo specifico è possibile impostare un percorso di cura mirato e personalizzato.